Contenuto in abbonamento
Lontano dai riflettori delle cronache un intenso lavoro di analisi e confronto sta progettando la produzione a basso impatto del prossimo futuro. L’entrata in vigore del Regolamento Ecodesign (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), il 28 luglio 2024 ha dato il via a un processo attuativo che passa dall’approvazione di atti delegati e atti esecutivi da parte della Commissione Europea. Il cronogramma della prima parte di questo processo, da qui al 2030, è stato emanato a metà aprile, mentre tra il 19 e 21 febbraio scorsi si è riunito per la prima volta a Bruxelles l’Ecodesign Forum, organismo consultivo composto da Stati membri, organizzazioni provenienti da una vasta gamma di settori economici e produttivi, ONG e associazioni ambientaliste, “per garantire un’attuazione trasparente e partecipativa dell’ESPR”. L’Italia ha preso parte a questo processo attraverso i propri rappresentanti nell’ambito del citato Ecodesign Forum, ma anche insediando, lo scorso 13 marzo, il Tavolo Ecodesign presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. EconomiaCircolare.com ha fatto il punto della situazione con l’ingegner Pietro Agrello, dirigente della Divisione II della Direzione generale Sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC) del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Ingegner Agrello, ci aiuti a ricostruire l’iter che ha portato all’istituzione del Tavolo Ecodesign italiano: come ci si è arrivati e da chi è composto?
Partiamo dal fatto che nel 2022 il ministero ha approvato la Strategia per l’economia circolare, che tra le altre cose assegna un ruolo importante all’ecodesign. Il cronoprogramma, che tra l’altro è stato aggiornato di recente, prevede anche l’istituzione di un Tavolo Ecodesign, che comprende peraltro anche un gruppo di lavoro su riutilizzo e riparazione. In questa cornice a novembre 2024, con decreto del Capo dipartimento dello Sviluppo sostenibile, il Mase ha istituito appunto il Tavolo. Esso è composto da rappresentanti del ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Imprese del Made in Italy, ma ci sono anche enti di ricerca – quali Enea, Cnr, Ispra – rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, Accredia, UNI, CNA, CONAI, RSE e una serie di università e Politecnici, quali i Politecnici di Milano, di Torino e di Bari e le Università Federico II di Napoli, Sant’Anna di Pisa e IUAV di Venezia. Dunque un quadro abbastanza variegato di stakeholder.
Qual è, in sintesi, lo scopo del Tavolo Ecodesign e come si relaziona con la Commissione Ue per l’attuazione dell’ESPR?
Il compito principale del tavolo è quello di supportare le amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Regolamento Ecodesign, innanzitutto nella “fase ascendente”, per contribuire a definire il contenuto degli atti delegati, con i quali la Commissione disciplinerà in concreto i requisiti di progettazione ecocompatibile per ciascun settore merceologico. In pratica gli orientamenti proposti dal Tavolo concorreranno alla formazione della posizione nazionale che verrà espressa nelle sedi deputate, quali il citato Forum Ecodesign e il Gruppo di esperti degli Stati membri previsti dal Regolamento ESPR.
Ma anche, successivamente, in quella che potremmo definire “fase discendente”: dopo che questi atti delegati saranno approvati, introducendo i criteri di ecoprogettazione e altre prescrizioni, bisognerà analizzare questi atti e favorire la loro applicazione.
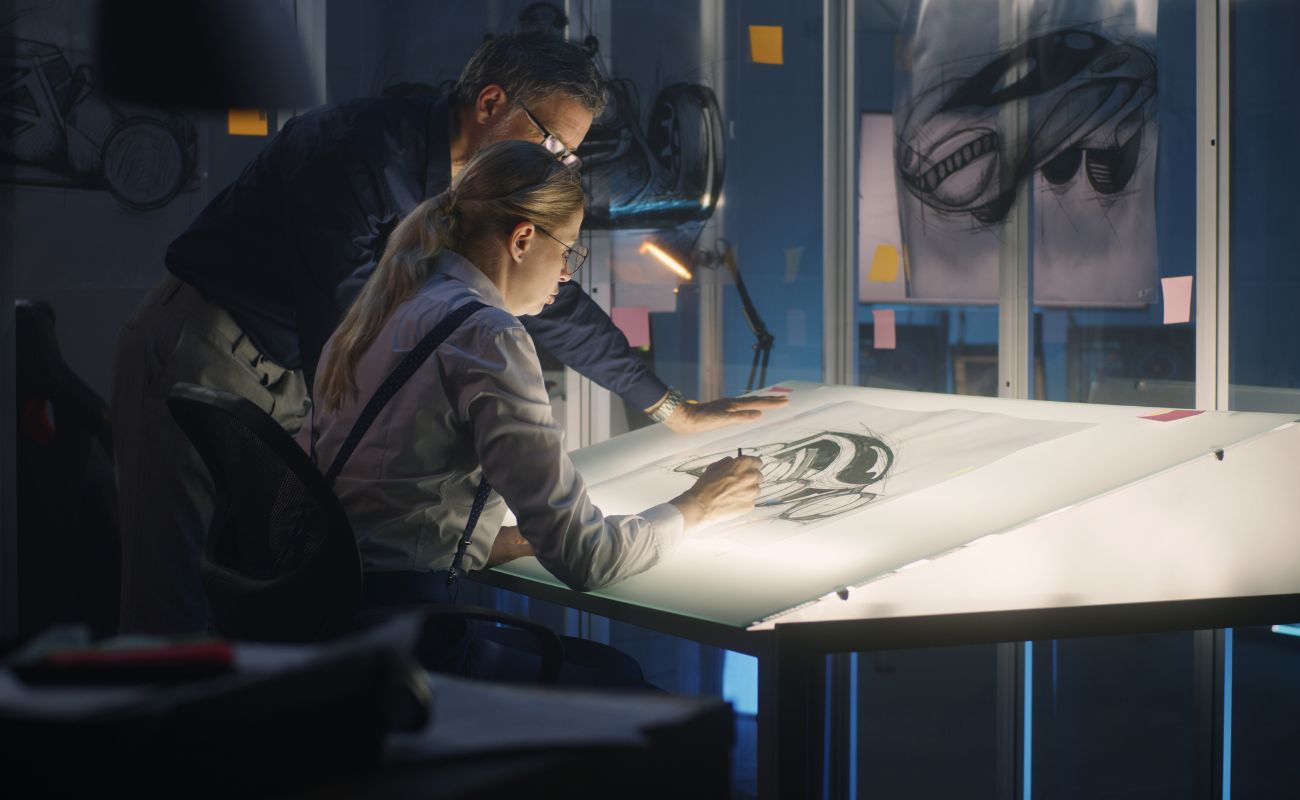
Leggi lo speciale Ecodesign
La prima riunione del Tavolo Ecodesign aveva già diverse questioni da affrontare: qual è stato l’ordine del giorno?
In effetti è stata una riunione di insediamento, ma non solo formale. Si è già discusso di temi concreti, anche alla luce degli incontri del 19, 20 e 21 febbraio del Forum per la progettazione ecocompatibile e del Gruppo di esperti degli Stati membri, un sottogruppo del Forum: sono organi consultivi con cui la Commissione si confronta ai fini dell’emanazione degli atti delegati Uno dei punti fondamentali della discussione, nel corso della prima riunione del 13 marzo scorso, è stato proprio quello di condividere l’edito della discussione fatta in sede europea con i componenti del tavolo.
E di cosa hanno discusso a febbraio l’Ecodesign Forum e il gruppo di esperti degli Stati membri?
Possiamo dire di due macro-temi: della proposta, poi successivamente approvata, del primo piano di lavoro della Commissione, e del tema della distruzione dei beni invenduti previsto dal regolamento Ecodesign. A tal riguardo il Regolamento prevede un divieto di distruzione dei beni invenduti per determinate categorie di prodotti, in particolare abbigliamento e calzature, e degli obblighi informativi per tutti gli operatori economici che si disfino di prodotti di consumo invenduti, escluse le micro e le piccole imprese. Anche su questo versante si prevede l’emanazione di atti esecutivi o delegati: quelli esecutivi per disciplinare in che modo, con quale livello di dettaglio, con quale classificazione le imprese dovranno diffondere queste informazioni, mentre con gli atti delegati si andranno a stabilire le deroghe al citato divieto di distruzione.
Passiamo al piano di lavoro 2025-2030 comunicato dalla Commissione: in che modo il Tavolo Ecodesign presso il Mase ne accompagnerà l’attuazione?
Il Regolamento aveva già definito dei settori prioritari per i quali sviluppare i criteri di eco-progettazione, confermati ora, in linea generale, salvo alcune esclusioni, dal piano quinquennale 2025-2030, con revisione al 2028, che stila di fatto un cronogramma dei primi atti delegati volti a definire i citati criteri: si parte con ferro e acciaio, alluminio, prodotti tessili con particolare attenzione all’abbigliamento, mobili, pneumatici, materassi e prodotti connessi all’energia.
Poi ci sono due atti orizzontali relativi uno alla riparabilità e l’altro alla riciclabilità e al contenuto di materiale riciclato nei dispositivi elettronici ed elettrici. Si dovrebbe partire tra fine 2026 e inizio 2027 con l’atto delegato relativo al tessile e quello su ferro e acciaio. Da questo discende l’organizzazione del Tavolo Ecodesign: abbiamo deciso di organizzare il lavoro in gruppi settoriali che vanno più o meno a ricalcare gli ambiti prioritari individuati nel primo piano di lavoro della Commissione. Sono stati istituiti per ora 5 gruppi di lavoro: un gruppo di lavoro sul tessile, uno su ferro, acciaio e alluminio che dunque va a inglobare due degli atti delegati previsti, uno su riparabilità e riciclabilità che anche in questo caso mette insieme i due atti orizzontali della Commissione, e uno sui prodotti connessi all’energia. Successivamente attiveremo anche il gruppo di lavoro sugli arredi.
Leggi anche: Regolamento Ecodesign, la Commissione UE pubblica il piano di lavoro 2025-2030
Come si compongono i gruppi di lavoro?
Abbiamo chiesto ai componenti del Tavolo di candidarsi a far parte di uno o più gruppi in base alle loro competenze ed esperienze. E abbiamo chiesto loro di estendere l’invito ad eventuali altri esperti della propria Amministrazione/Ente di appartenenza. Abbiamo anche raccolto candidature per il coordinamento dei gruppi di lavoro, quindi ogni gruppo avrà due coordinatori, diversi componenti individuati in base alle competenze e poi due referenti della Direzione Sostenibilità dei prodotti e dei consumi, la Direzione generale del MASE che segue principalmente il tema dell’ecodesign, per un supporto tecnico e organizzativo.
C’è un calendario di convocazione del Tavolo Ecodesign e dei diversi gruppi di lavoro?
L’idea è quella che il tavolo nella sua conformazione plenaria si riunisca almeno una volta l’anno. Per i gruppi di lavoro invece, le riunioni saranno convocate in autonomia in maniera più flessibile, anche in base alle tempistiche dettate dalla Commissione per l’emanazione degli atti. Il lavoro di questi gruppi di lavoro e poi del Tavolo nel suo complesso rappresenta un momento di analisi e confronto preliminare, con approfondimenti anche molto tecnici, con l’obiettivo di contribuire a determinare le posizioni che il nostro Paese esprimerà nelle sedi europee deputate.
Sulla definizione dei criteri di ecoprogettazione l’Italia può fare affidamento su una solida base di elaborazione legata ai criteri ambientali minimi – i cosiddetti CAM – finalizzati agli acquisti verdi della pubblica amministrazione, peraltro incentivati anche dal Regolamento Ecodesign.
In effetti i gruppi di lavoro potranno consultare anche altri stakeholder ed esperti a seconda delle necessità e si potrà seguire in linea generale il metodo di lavoro che il Ministero già adotta per l’emanazione dei CAM. Nell’ambito dei CAM, infatti, esistono già tavoli tecnici settoriali, consultivi, finalizzati a definire questi criteri che poi dovranno essere applicati dalle stazioni appartanti nelle procedure di gara. Peraltro il nostro auspicio è anche quello di favorire per quanto possibile la convergenza tra i criteri ambientali minimi che abbiamo già sviluppato in ben 21 settori merceologici – e che a differenza di altri Paesi europei prevediamo come obbligatori nel nostro Codice dei contratti pubblici – e quelli che saranno i criteri di ecoprogettazione individuati con gli atti delegati dell’ESPR.
Ci fa un esempio di un settore dove questa convergenza è a portata di mano?
Per esempio, i CAM per i prodotti tessili già prevedono molti criteri, quali quelli relativi al contenuto di riciclato, alla presenza – da ridurre – di sostanze pericolose o alla durabilità del prodotto, che in effetti sono in perfetta sintonia con i criteri di ecoprogettazione.
A questo proposito, guardando agli aspetti più operativi, va aggiunto che nelle riunioni del Forum europeo dello scorso febbraio si è parlato anche delle regole di funzionamento del Forum e si è detto che la Commissione si impegna a condividere almeno 30 giorni prima di ogni riunione i documenti tecnici che poi saranno oggetto di discussione. Dopo ogni riunione gli Stati membri avranno ulteriori 30 giorni per presentare le proprie osservazioni. Un paio di mesi complessivi, dunque, per discutere di questi documenti con i gruppi di lavoro e arrivare a formulare osservazioni e proposte da far pervenire eventualmente alla Commissione per il tramite degli organi a ciò deputati (Forum Ecodesign e Gruppo di esperti degli Stati membri).
Leggi anche: Ecodesign Forum: lo strumento di partecipazione per le norme sulla sostenibilità dei prodotti europei
Oltre che all’interno dei ministeri competenti, è previsto che il Tavolo italiano compia dei passaggi con il Parlamento o altre istituzioni del nostro Paese?
Non è previsto un passaggio di questo tipo, nel senso che il Regolamento ESPR delega alla Commissione europea l’emanazione di atti delegati per disciplinare aspetti tecnici o di dettaglio. A tal fine la Commissione consulta il Forum e il Gruppo di esperti degli Stati membri, i cui pareri non sono vincolati, e dovrà in qualche modo mediare, come sempre avviene, tra le diverse posizioni prima di emanare l’atto. In questo quadro si inserisce il lavoro del Tavolo nazionale che, come già detto, punta a fornire suggerimenti e osservazioni da portare al Forum europeo, peraltro analizzando con particolare attenzione aspetti di tipo tecnico, come si evince anche dalla composizione del Tavolo.
Avete discusso all’interno del Tavolo del tema del passaporto digitale del prodotto, che insieme al Green public procurement è un altro elemento caratterizzante del regolamento Ecodesign?
Ne abbiamo parlato perché tra i punti all’ordine del giorno della prima riunione c’era una panoramica generale del Regolamento. Del passaporto abbiamo parlato come previsione normativa non scendendo ancora nei dettagli, anche perché lo stesso strumento del passaporto digitale avrà bisogno di essere definito e disciplinato in concreto con appositi atti della Commissione. Ovviamente si tratta di uno strumento fondamentale, e questo lo abbiamo sottolineato, che avrà peraltro importanti ripercussioni anche sulla vigilanza del mercato e sulle relative attività sia delle Autorità di vigilanza, tra cui c’è anche il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, sia degli Uffici doganali che dovranno fare i controlli.
Chiudiamo con un focus su quello che, a quanto pare, è il prossimo step attuativo del Regolamento quadro sull’ecoprogettazione: il divieto di distruzione dell’invenduto. Possiamo approfondire tempi e modalità?
Il divieto di distruzione è relativo in sostanza ad abbigliamento e calzature. Tale divieto non si applica alle micro e piccole imprese, mentre si applicherà alle grandi imprese a partire dal 19 luglio 2026 e alle medie a decorrere dal 19 luglio 2030. Fatto salvo questo divieto generale, il Regolamento prevede la possibilità di disciplinare delle deroghe: ad esempio per ragioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza. Però queste particolari deroghe dovranno essere disciplinate anche in questo caso attraverso atti delegati della Commissione. Il primo di questi atti delegati dovrebbe essere emanato a luglio 2025, quindi tra pochi mesi.
Poi c’è il discorso, che vale in maniera trasversale per tutti i settori, dell’obbligo di divulgare informazioni in merito ai beni invenduti dei quali gli operatori economici si sono disfatti. Anche qui il Regolamento dà una cornice generale ed entro luglio si attende un atto esecutivo della Commissione volto a definire in che modo le imprese dovranno diffondere le informazioni sui beni invenduti: si tratta di stabilire aspetti quali il livello di dettaglio o la granularità delle informazioni raccolte e divulgate, oppure i codici di classificazione dei beni, tutti aspetti non banali, perché da una parte si deve garantire la trasparenza e l’efficacia dell’ informazione e dall’altra bisogna evitare di gravare le imprese con oneri eccessivi. Quindi si tratterà di trovare un equilibrio tra queste due esigenze.
© Riproduzione riservata





