Per chi segue la cronaca locale non è una novità che i cavi di rame vengano spesso prelevati e rubati. Il rame metallico ha infatti svariati usi, sia da solo che in leghe metalliche composte grazie all’unione con ottone e bronzo, dalle tubature per il trasporto di liquidi ai cavi elettrici, dalle monete ai pannelli solari.
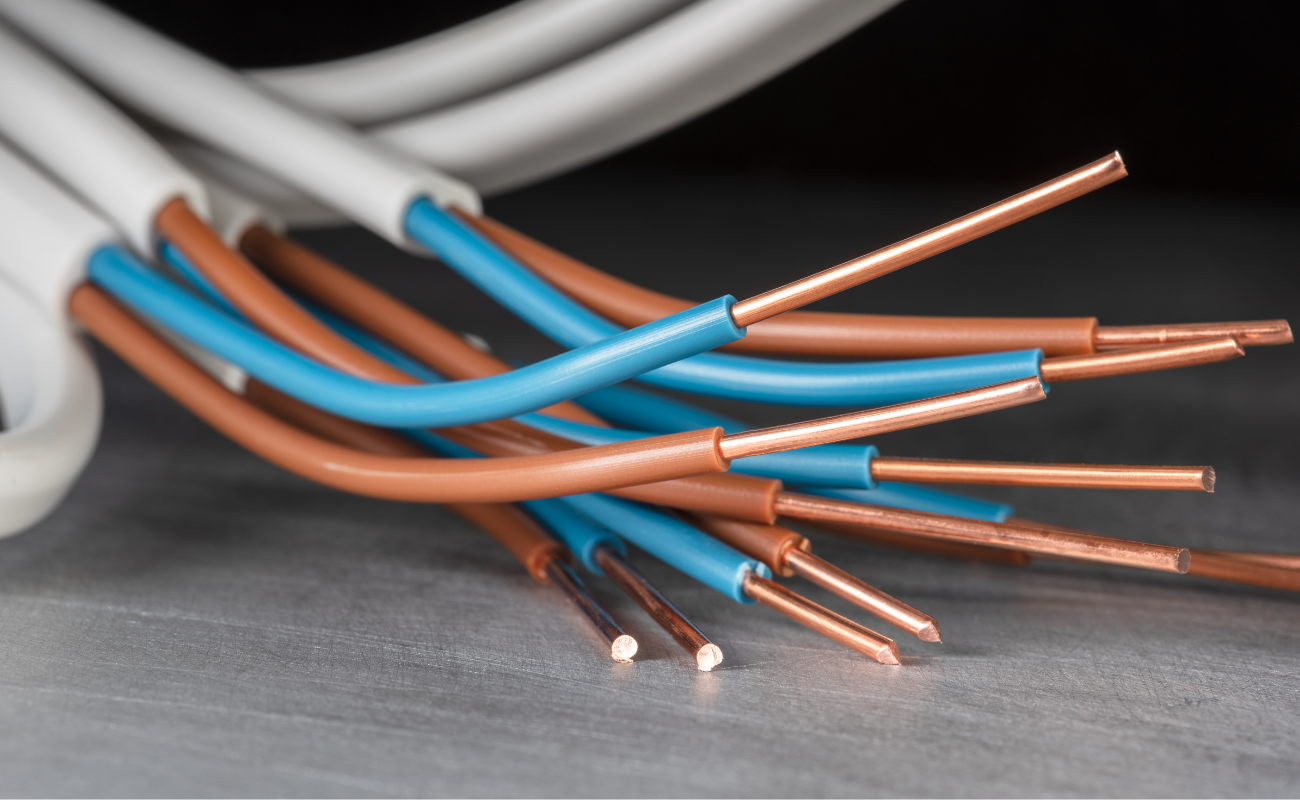
Nonostante l’importanza del rame metallico in più industrie, l’Italia è altamente dipendente dall’importazione: stando allo UGSG Minerals Yearbook la produzione casalinga di rame, da metallurgia o riciclo, è stata di un peso lordo di 15.400 tonnellate, mentre il minerale di rame non risulta affatto tra le risorse minerali non energetiche estratte.
Nello stesso anno l’Italia ha importato rame per un valore di 5.34 milioni di dollari, e il valore economico medio per una tonnellata di rame è stato di 9.317,49 dollari. Possiamo quindi stimare che nel corso del 2021 l’Italia abbia importato circa 573.162,407 tonnellate di rame a fronte delle 15.400 tonnellate prodotte in autonomia: una percentuale relativamente bassa che si aggira intorno al 2,7% del fabbisogno nazionale.
Nel 2024 in Italia sono stati correttamente raccolti più di 356 milioni di chilogrammi di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o RAEE, quasi 9 milioni in più rispetto all’anno precedente. Il miglioramento, frutto di un esercizio continuo di sensibilizzazione della cittadinanza, è avvenuto in seguito a una decrescita delle quantità raccolte: già nel 2022, infatti, la raccolta di RAEE aveva superato i 360 milioni di chilogrammi.
Leggi anche: Niente fondi PNRR per gli impianti di trattamento delle schede RAEE
La domanda di rame è destinata ad aumentare
L’indipendenza da Paesi terzi diventa un argomento particolarmente di rilievo con l’European Critical Raw Materials Act, entrato in vigore a maggio 2024. Il regolamento invita gli Stati membri dell’Unione Europea a migliorare il tasso di utilizzo circolare di materia, o CMU, per far sì che entro il 2030 il fabbisogno di materie prime strategiche possa essere coperto almeno al 25% da materie prime secondarie. Inoltre gli Stati membri devono lavorare “affinché entro il 2030 l’Unione non dipenda per oltre il 65% da un unico Paese terzo per quanto riguarda l’approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica”. L’obiettivo del Critical Raw Materials Act potrebbe risultare ambizioso dato che, nel 2023, il contributo delle materie prime secondarie al fabbisogno globale è stato solo del 7,2%. L’Italia è riuscita a distinguersi portando, nel 2022, la percentuale al 18,7%, un buon risultato rispetto alla media europea dell’11,5%.
A livello globale la produzione da riciclo per quanto riguarda metalli e minerali è ancora marginale rispetto alla domanda, dato che una quantità significativa di materiale viene persa tra rifiuti non riciclati e processi di smaltimento impropri, ma la capacità di tracciare e riciclare è tanto più importante quanto è minore la possibilità di procurarsi il metallo in casa, come nel caso dell’Italia.
Il rame è un elemento fondamentale, la cui importanza non fa che crescere considerando il suo recente ruolo di spicco nel funzionamento dell’Intelligenza Artificiale (spesso abbreviata con la siglia IA o il corrispondente inglese AI, Artificial Intelligence), anche nella vita di tutti i giorni: gli apparecchi elettrici ed elettronici appartenenti a tutte le cinque classificazioni dei RAEE contengono spesso rame, partendo dai circuiti elettronici e i cavi di alimentazione (in un telefono cellulare il rame può arrivare a rappresentare il 20% del peso totale del dispositivo) per arrivare ai trasformatori e ai motori elettrici. Persino la classificazione R5, relativa alle sorgenti luminose, dipende dal rame per quanto riguarda cablaggi e componenti dei reattori.

Stando al Global Critical Minerals Outlook 2024, al 2023 la richiesta di rame nell’ambito della cleantech, la “tecnologia pulita”, ammonta al 25% della domanda totale ed è destinata a crescere in ognuno degli scenari previsti dall’International Energy Agency. È sempre l’IEA a mostrare come la metà del rame da estrazione mineraria utilizzato a livello globale provenga da miniere situate in Cile, nella Repubblica Democratica del Congo e in Perù; quella del rame da raffinazione da Cina, Russia e di nuovo Cile. Il resto del mondo contribuisce rispettivamente al 34% circa della produzione nel caso del rame da estrazione, al 36% circa nel caso del rame da raffinazione. L’uso del rame nell’ambito cleantech è infatti rilevante per vari ambiti dell’energia a basse emissioni, come fotovoltaico ed eolico, ma anche per la manifattura di veicoli e reti elettriche, grid battery storage e tecnologie dell’idrogeno.
Leggi anche: Sull’energia l’UE ha poche e confuse idee
Apple insegna che usare rame riciclato è necessario
Apple, nel rendere accessibile il report ambientale dei recenti iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, ha sottolineato come sia stato usato rame riciclato nei circuiti stampati, nel Taptic Engine e nel caricabatterie induttivo, una prova del fatto che il recupero di questo materiale sia effettivamente possibile e si possa immaginare di integrare sempre di più le materie prime secondarie in ambiti produttivi di alto livello. Nonostante il lavoro continuo che mira a un miglioramento dei tassi di raccolta e riciclo, l’Italia e l’Europa si trovano ancora a dipendere fortemente dalle importazioni di rame, con tutte le implicazioni geopolitiche ed economiche del caso.
L’impegno crescente per una gestione delle risorse più consapevole è reso evidente da regolamenti come l’European Critical Raw Materials Act e da iniziative aziendali come quelle di Apple, ma se da un lato l’uso di rame riciclato potrà contribuire in modo significativo alla copertura del fabbisogno, dall’altro sono e saranno necessari investimenti maggiori nelle tecnologie di recupero oltre a una maggiore sensibilizzazione sul tema del riciclo. Solo così l’Italia, e l’Unione Europea, potranno ridurre davvero la propria dipendenza dai Paesi terzi e rendere più sostenibile l’approvvigionamento, e l’uso, di metalli essenziali.
Leggi anche: I numeri e le proposte della filiera degli elettrodomestici
© Riproduzione riservata
Questo articolo è uno degli elaborati pratici conclusivi della nona edizione del corso online di giornalismo d’inchiesta ambientale organizzato da A Sud, CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali ed EconomiaCircolare.com in collaborazione con il Goethe Institut di Roma, il Centro di Giornalismo Permanente e il Constructive Network




