Se non verranno fissati limiti alla produzione e consumo di PFAS, i costi di bonifica in Europa supereranno i 100 miliardi di euro l’anno. A stimare quanto costerà bonificare le aree europee più gravemente contaminate dalle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche è il Forever Lobbying Project, alleanza di media europei che nel 2023 ha mappato la portata della contaminazione da PFAS in tutta Europa e che qualche settimana fa ha pubblicato un nuovo dossier.
In cui, oltre a pesare i costi occulti dei PFAS, ha passato al vaglio le argomentazione usate per convincere i decisori europei a non introdurre limitazioni alla produzione e all’uso di queste sostanze. Scoprendo che le lobby si servono di argomentazioni che in molti casi sono “allarmistiche, false, fuorvianti o potenzialmente disoneste”.
Insomma, quella pro-PFAS è una “campagna di disinformazione orchestrata dalle lobby della chimica e della plastica”.
Leggi anche lo SPECIALE | PFAS
Il progetto giornalistico
46 giornalisti in 16 Paesi affiancati da 18 accademici e giuristi internazionali – quella che si autodefinisce una “pionieristica collaborazione transfrontaliera e interdisciplinare” – ha messo a punto il concetto di “expert-reviewed journalism” (“giornalismo esaminato da esperti”, sulla falsariga della revisione tra pari, peer review, delle pubblicazioni scientifiche). Questo team interdisciplinare, in collaborazione con l’osservatorio delle lobby europee Corporate Europe Observatory e con il PFAS Project Lab, ha raccolto oltre 14.000 documenti inediti sui PFAS: “La più grande collezione al mondo sull’argomento”, ora disponibile al pubblico nella Industry Documents Library dell’Università della California, San Francisco e nel database Toxic Docs della Columbia University, New York, e della City University of New York.

La richiesta di bando e il lavoro delle lobby
Nel febbraio 2023 Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia hanno avanzato la proposta di bando (con eccezioni) per circa 10 mila sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche. Una proposta in corso di valutazione tecnica da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che non poteva lasciare indifferente chi quelle sostanze le produce e le utilizza. E così, raccontano gli autori dell’inchiesta, “centinaia di operatori del settore che difendono gli interessi di circa 15 settori hanno esercitato pressioni sui responsabili delle decisioni in tutta Europa per indebolire, e forse bloccare, la proposta”.
L’indagine descrive come i lobbisti dell’industria ricorrano a tattiche di influenza “tipiche del mondo aziendale, utilizzate nel corso dei decenni per difendere il tabacco, i combustibili fossili e altri prodotti chimici e pesticidi”.
Spiegano gli autori: “Abbiamo selezionato 1.178 argomenti di lobbying dalla nostra collezione di 8.189 documenti per sottoporli a uno stress test”. Oltre la metà di questi documenti è stata raccolta tramite richieste di accesso agli atti (Freedom of Information requests – FOI) in 16 Paesi europei. Altri sono arrivati da Corporate European Observatory, che ha presentato 66 richieste FOI alle istituzioni europee. E poi ci sono tutte le osservazioni – oltre tremila – ricevute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) tra marzo e settembre 2023 durante la consultazione pubblica sulla citata proposta di restrizione ai PFAS.
Per ‘testare’ le argomentazioni delle lobby è stata messa a punto, con l’aiuto di Gary Fooks, ricercatore dell’Università di Bristol, Regno Unito, una metodologia per vagliarne l’affidabilità. Cosa emerge da questo poderoso fact checking? “Inostro stress test dimostra che nessuno dei loro sette argomenti dominanti è supportato dalla scienza attuale: quattro sono falsi, due sono fuorvianti e l’argomento chiave è potenzialmente disonesto”.
I documenti analizzati da giornalisti e ricercatori (qui la metodologia impiegata per gli ‘stress test’), “hanno fatto riferimento 997 volte a due articoli scientifici i cui autori sono dipendenti o consulenti dell’industria per affermare che i fluoropolimeri sono ‘polimeri poco preoccupanti (polymer of low concern –PLC) secondo i criteri stabiliti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)’”, si legge. Ma andando a verificare se veramente le molecole oggetto dell’indagine rientrino nei criteri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, i giornalisti hanno scoperto che “criteri PLC” semplicemente non esistono. L’Organizzazione ha confermato al Forever Lobbying Project che “non è stata messa a punto una serie di criteri concordati a livello OCSE” e che, addirittura, non è stata condotta nessuna valutazione dei fluoropolimeri (la dichiarazione dell’OCSE e tutti i documenti citati nell’inchiesta sono a disposizione dei lettori nella sezione documenti del sito web del progetto).
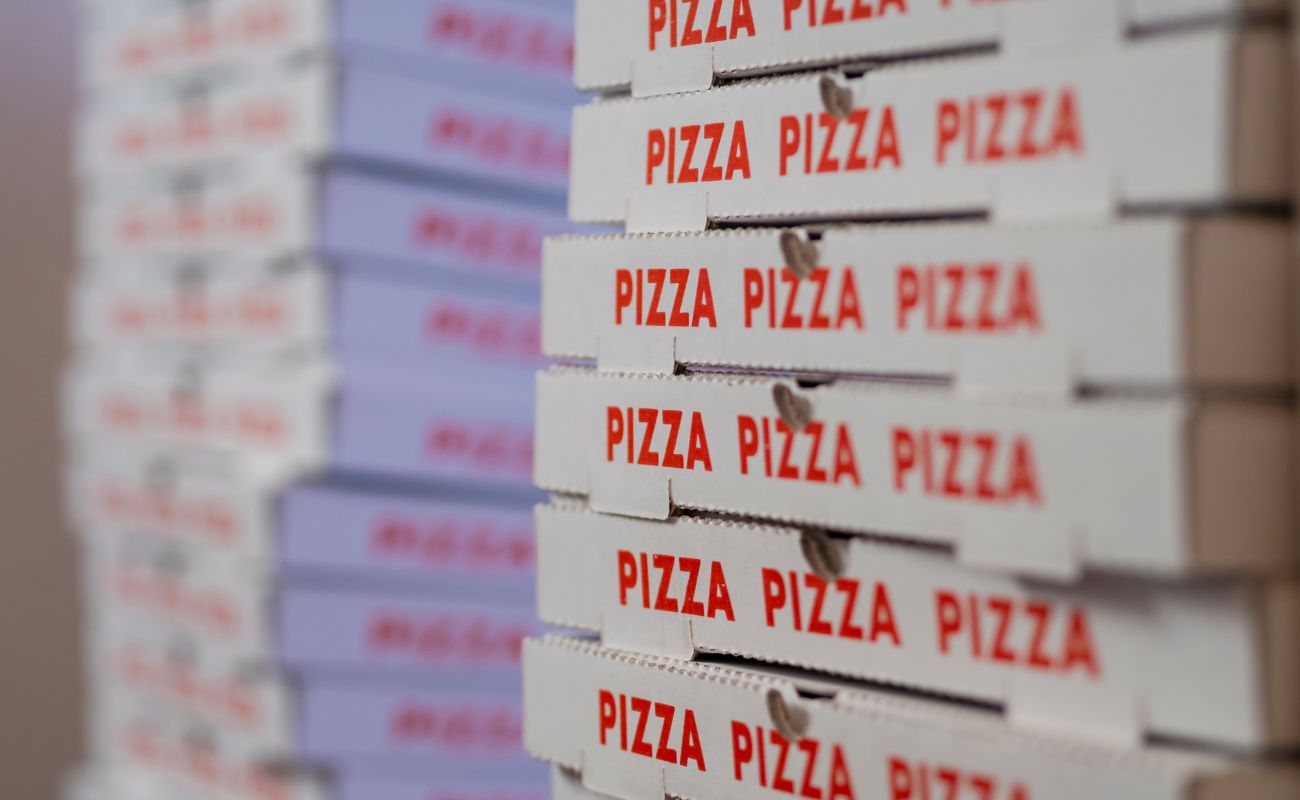
Leggi anche: Greenpeace: “Positivo ai PFAS l’80% dei campioni di acqua potabile raccolti in Italia”
“Non c’è alternativa”
Come sappiamo tra gli argomenti usati più spesso da chi contesta la necessità, e la possibilità, di fare a meno dei PFAS quello sulla possibilità di sostituirli con delle alternative. “Sono tutti argomenti a cui la Commissione europea è molto sensibile”, scrivono gli autori. “La stessa Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha riassunto questo punto in una lettera dell’aprile 2024: ‘I PFAS sono attualmente necessari per applicazioni critiche per la transizione verde e digitale e per l’autonomia strategica dell’UE, ad esempio nei semiconduttori, negli elettrolizzatori, nelle celle a combustibile, nelle batterie e nei componenti per molti settori, tra cui la difesa, l’aerospaziale e la medicina’”.
Eppure “il nostro stress test sull’affermazione che ‘non ci sono alternative’ ha rilevato che esiste un numero sempre crescente di potenziali alternative”, affermano i giornalisti.
Nel dettaglio: “Abbiamo raccolto 525 dichiarazioni di operatori del settore che rientrano nella categoria ‘non c’è alternativa’. Solo 134 contenevano informazioni sufficienti per identificare un’applicazione precisa. Per aiutarci a testare queste dichiarazioni, abbiamo contattato Ian Cousins e Romain Figuière, entrambi dell’Università di Stoccolma. Nell’Alternative Assessment Database, sviluppato dai ricercatori nell’ambito del progetto ZeroPM finanziato dall’UE, sono presenti potenziali alternative per quasi due terzi di questi 134 casi”. E poi: “Abbiamo scoperto che, in molti casi, le aziende non sono riuscite a sostenere le loro affermazioni di ‘assenza di alternative’ nelle loro proposte all’ECHA”.
Le stime dei costi
Se le analisi sugli argomenti delle imprese fa venire qualche dubbio sulle azioni di lobbying, le stime sui costi possono spaventare. “Secondo gli scienziati, le autorità di regolamentazione e la società civile, il ‘veleno del secolo’ ha creato la peggiore crisi di inquinamento che l’umanità abbia mai affrontato”, affermano gli autori dell’inchiesta. Per provare a capire quanto potrebbe costare ripulire dai PFAS le acque e i suoli più contaminati in Europa, è stata elaborata una metodologia con Ali Ling (Università di St. Thomas, Stati Uniti) e Hans Peter Arp (Università Norvegese di Scienza e Tecnologia).
Due gli scenari ipotizzati. Il primo è lo scenario “legacy” (eredità), in cui si immagina che le emissioni di queste molecole cessino immediatamente e quindi che solo i PFAS a catena lunga (i primi ad essere prodotti e utilizzati, alcuni dei quali giudicati unanimemente pericolosi, come PFOS e PFOA) – vengono bonificati. In questo scenario, “il costo è di circa 95 miliardi di euro in 20 anni”.
Nel secondo scenario, definito “emergente”, le emissioni di PFAS in ambiente continuano e gli sforzi di bonifica considerano quindi anche molecole più recenti (quelle a catena corta e ultra-corta, più difficili da trattare). In questo scenario “i costi salgono a circa 2.000 miliardi di euro nei prossimi 20 anni”. Ma attenzione: si tratta comunque di sottostime, visto che “questi calcoli non includono un’ampia gamma di costi sconosciuti a causa della mancanza di conoscenze e di fonti di dati”.
Aggiornamento del 31 gennaio 2025
Robert Bilot, l’avvocato statunitense che ha legato il proprio nome, e la propria fama, alla lotta contro l’inquinamento da PFAS e contro le imprese che ne sono responsabili, qui racconta della sua esperienza nelle cause contro la DuPont, e delle campagne di disinformazione dei produttori di queste molecole.
© Riproduzione riservata




