Qualche tempo fa creò sconcerto l’intervista della BBC a Raoul Thulin, figlio dell’ingegnere svedese che nel 1965 brevettò insieme a due colleghi le famigerate buste di plastica a “t shirt” – ovvero quelle con i manici – oggi emblema dell’usa e getta che crea disastri ambientali. Raoul in quell’intervista ribalta la prospettiva e racconta che il padre pensava di donare al mondo una soluzione ecologica in grado di evitare l’abbattimento di centinaia di alberi per creare sacchetti di carta, allora distribuiti in mercati e negozi per il trasporto della mercanzia. “Mio padre avrebbe trovato bizzarro l’utilizzo delle buste di plastica una sola volta – dice Thulin figlio – ne portava sempre una ripiegata in tasca. Lo faceva naturalmente perché… perché non bisognerebbe farlo?”.
L’ingegner Thulin lavorava per un’azienda chiamata Celloplast di Norrkoping, una città svedese che si affaccia sul Mar Baltico e che produceva viscosa. Il brevetto – come è noto – ebbe un enorme successo e la ditta di Norrkoping sbarcò presto negli Usa grazie a Bob “Bagsey” Siegel che vide per la prima volta il prototipo dello shopper in plastica alla fiera Ipack Ima di Milano, capendo subito le enormi potenzialità di quell’invenzione e fondando la Celloplast USA. Vent’anni dopo non c’era persona in qualsiasi parte del mondo che uscisse da un supermercato senza una – e spesso molte – buste di plastica. Da buttare nella spazzatura non appena svuotate, o utilizzate altre due o tre volte e infine, magari, disperse nell’ambiente.
Non è dato sapere con certezza se davvero la creatività di Thulin fu alimentata da spirito ambientalista, è certo però che nei documenti del brevetto si legge che questo tipo di buste sarebbero state molto più resistenti di quelle di carta, che invece tendevano a strapparsi. Resistenti lo erano davvero, talmente tanto da essere di fatto immortali. Una busta di plastica infatti per “scomparire” impiega dai 10 ai 20 anni, ma in realtà non scompare mai: il polimero che la compone si separa in piccolissimi pezzi che restano in ambienti come gli oceani per un tempo indeterminato, assorbendo peraltro sostanze tossiche. Il problema creato dai sacchetti di plastica è noto e dibattuto, fatto sta che se ne continuano a buttare troppi e di conseguenza a produrre troppi. Se volete sapere quanti, in questo preciso istante, date un’occhiata qui
Messa al bando dei sacchetti, la lunga marcia
La lunga lotta contro i sacchetti di plastica è cominciata vent’anni fa e oggi la situazione è certamente migliorata, anche se non sempre le normative riescono a essere efficaci e l’esperienza ha insegnato che non per forza e non in ogni situazione i nuovi materiali sono migliori della plastica.
I Paesi che hanno messo al bando le buste costruite con questo materiale sono ormai centinaia e l’Italia è stato il primo in Europa, dovendo peraltro superare parecchi ostacoli. Il Bangladesh, dove ancora oggi esiste un fortissimo movimento contro i rifiuti di plastica, rompe gli indugi nel 2002 quando diventa chiaro a tutti che sono proprio gli shopper abbandonati senza criterio a ostruire i sistemi fognari e a peggiorare la situazione in caso di alluvioni.
Pochi anni dopo è la volta dell’Italia: ricordando che già nel 1988 un decreto aveva imposto una tassazione alle buste di plastica (100 lire per unità di fabbricazione), la legge finanziaria 2007 (governo Prodi II, ministro dell’Ambiente Pecoraro Scanio) apre una breccia importante, in modo però abbastanza vago: promette che verrà avviato un programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica non biodegradabili “per l’asporto delle merci” con il fine di “ridurre l’anidride carbonica” e sostenere “le filiere agroalimentari nel campo dei biomateriali”. Un vero e proprio scatto in avanti del nostro Paese, dovuto senza dubbio alla presenza di un movimento ambientalista competente e strutturato, ma anche alla competitività italiana sul mercato internazionale nel settore delle bioplastiche con l’azienda Novamont, nata all’interno del gruppo Montedison, che già nel 1990 comincia a produrre e vendere l’ormai famosissimo Mater-Bi, una bioplastica derivata dall’amido di mais. Lo stop alle buste di plastica doveva scattare il 1 gennaio 2010 ma in tre anni succede di tutto, inciampi e ricorsi con una superfetazione di leggi e sentenze da far ammattire un azzeccagarbugli.
Siamo così arrivati al 2009, mancano 12 mesi alla messa al bando, a Palazzo Chigi siede l’ultimo governo Berlusconi e la crisi finanziaria mondiale esplode in tutta la sua drammaticità: prima un decreto milleproroghe rimette indietro l’orologio di un anno e quando nel 2010 è ormai ora di prendere una decisione si vocifera del tentativo di voler rimandare ancora. La ministra dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo però si impunta e ottiene di non far slittare ancora il divieto: in Italia sarà vietato commercializzare buste di plastica non biodegradabili per il trasporto delle merci a partire dal 1 gennaio 2011. Ma sarà vero? Non proprio, perché in Europa non piace questo attivismo italiano, e su questo terreno giocano interessi contrastanti: chi produce plastiche e chi produce bioplastiche. L’Unionplast (l’unione delle aziende nazionali produttrici di materiali plastici) propone ricorso al Tar sostenendo che la data dell’1 gennaio 2011 non è proprio perentoria. Il Consiglio di Stato però ribatte che invece lo è eccome (sentenza del 18 Aprile 2011).
Non è ancora giunto il tempo, però, di cestinare definitivamente le buste di plastica: Bruxelles nel 2012 sottopone l’Italia a una procedura di infrazione appellandosi a un articolo breve breve contenuto in una direttiva risalente al ’62 e che stabilisce la conformità degli imballaggi: “Gli Stati membri non possono ostacolare l’immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva”. Ovviamente, erano anni in cui non si parlava di biodegradabilità.
Le nuove regole
In Italia nel frattempo si è insediato il governo presieduto da Mario Monti: è l’esecutivo che deve evitare il default del Paese attraverso una serie di riforme concordate con l’Unione europea. Come conciliare la volontà italiana di vietare i sacchetti di plastica e aprire la strada al settore delle bioplastiche, che ormai conta diverse aziende e centinaia di posti di lavoro, e le molte pressioni affinché questo non avvenga? Il 25 gennaio 2012, cioè a 25 giorni dal via libera al divieto di commercializzazione delle buste di plastica, arriva un decreto legge che cambia le carte in tavola più di quanto sembri. Il cuore del decreto sta nella differenziazione che viene costruita. Cioè: nel 2007 si parlava genericamente di “buste di plastica per l’asporto di merci”. Adesso le cose si complicano: per la prima volta viene introdotta la distinzione tra “sacchi monouso” – che dovranno assolutamente essere banditi se non comprovatamene biodegradabili – e “sacchi riutilizzabili” che invece potranno continuare a essere commercializzati anche se in plastica non biodegradabile, a patto che abbiano uno spessore superiore a 200 micron quando destinati agli alimenti e a 100 micron se destinati ad altri usi (i sacchi per l’abbigliamento ad esempio). Viene introdotta inoltre la differenza tra sacchi con “maniglia esterna alle dimensioni utili del sacco” (cioè il normale sacchetto della spesa inventato da Thulin) o quelle “con la maniglia interna alle dimensioni utili del sacco” (che vuol dire la borsa che spesso viene data in negozi di abbigliamento o di arredo, ma a volte anche nei negozi che vendono alimenti). Via libera alla plastica, dunque? Non proprio. Perché il decreto specifica che “per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate” tutti i sacchi che non siano biodegradabili “devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare”. Queste percentuali possono essere innalzate con successivi interventi (come infatti poi è stato). Il decreto, infine, stabilisce le sanzioni pecuniarie per chi non si conforma alla nuova norma, che sarebbero scattate il 21 agosto 2014.
Queste di fatto sono ancora oggi le regole che valgono su tutto il territorio nazionale, anche se per concludere la storia legislativa di questa lunga marcia verso la biodegradabilità dei sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri a uso alimentare, manca ancora qualche passaggio.
Intanto l’anno successivo viene pubblicato il decreto del 18 marzo, che completa il quadro specificando che i sacchi monouso per uso alimentare dovranno essere non solo biodegradabili, ma anche compostabili. Che tutte le buste possono essere cedute sia gratuitamente che a pagamento e che ovviamente sono ammessi alla vendita anche sacchi fatti in carta, fibre naturali, poliammide e qualsiasi materiale diverso dai polimeri. Stabilisce, inoltre, le regole dell’etichettatura: sulle buste dovrebbe essere sempre riportato non solo se sono biodegradabili e compostabili ma anche se sono di spessore superiore a 100 micron, 200 micron quando sono per uso alimentare.
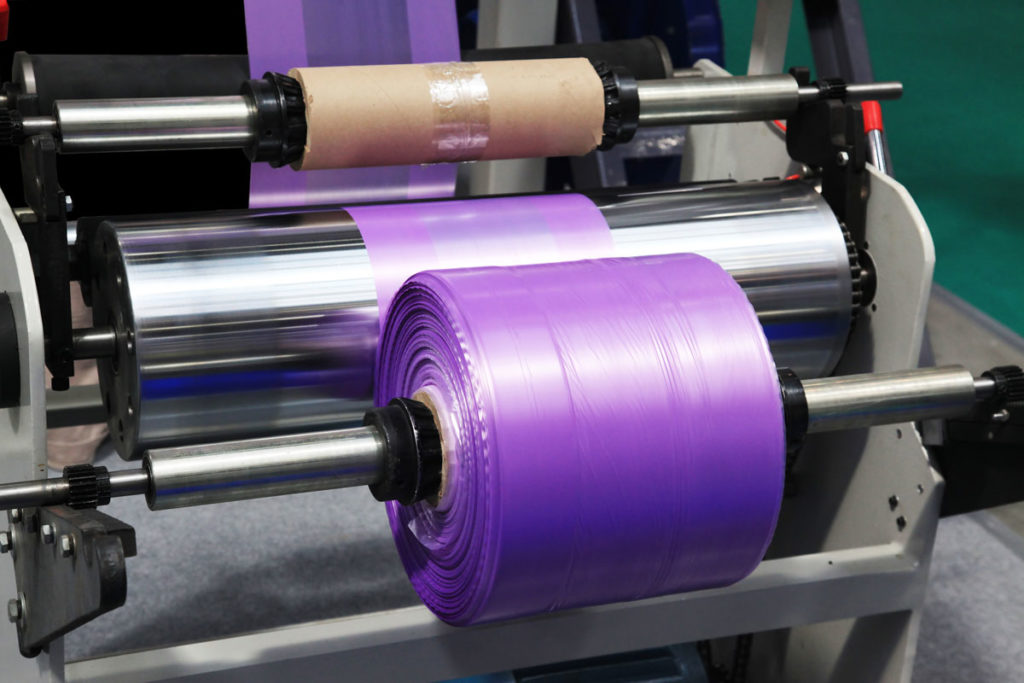
Una legge europea
Sembra che l’obiettivo di aprire la porta alle buste compostabili e biodegradabili (almeno le monouso in ambito alimentare!) sia ormai dietro l’angolo, ma devono ancora arrivare una nuova procedura d’infrazione dell’Unione europea (che contesta all’Italia di non aver comunicato l’introduzione dell’obbligatorietà della plastica riciclata nelle buste non biodegradabili) e la legge europea 2014, che pare rimettere tutto in discussione: per chiudere le procedure di infrazione e “fare pace” con Bruxelles si dice che saranno ammessi sul territorio italiano tutti i materiali compatibili con la direttiva del ’62.
La verità è che nel frattempo l’Unione europea ha fatto molti passi avanti. La messa al bando dei sacchetti di plastica non può più essere ignorata: il 29 Aprile del 2015 è stata approvata la direttiva 720, che cambia i connotati della direttiva sugli imballaggi e finalmente stabilisce la necessità di ridurre l’utilizzo di quelli in plastica, con una particolare attenzione alle buste di plastica leggere, quelle inferiori a 50 micron, che poi sono le classiche buste della spesa del supermercato. A questo proposito la direttiva parla chiaro: bisogna agire o facendole pagare o restringendone la commercializzazione (sempre rispettando “proporzionalità e non discriminazione”). Non solo: stabilisce due obiettivi ben precisi, da perseguire entrambi ove possibile, o almeno uno. Il primo prevede che entro il 31 dicembre 2019 vi sia un consumo di massimo 90 borse di plastica leggera pro capite; entro il 31 dicembre 2025 questo numero deve scendere a 40. Il secondo obiettivo è che entro il 31 dicembre 2018 le borse di plastica siano a pagamento “nei punti vendita di merci o prodotti”, a meno che non siano “adottati strumenti di pari efficacia”. Insomma per l’Ue il fine è chiarissimo: i sacchetti di plastica bisogna ridurli, non sostituirli.
Unica deroga concessa è per quelli ultraleggeri (con spessore inferiore a 15 micron) utilizzati “a fini igienici” o per “prodotti sfusi”, perché in qualche modo il loro utilizzo potrebbe essere legato alla prevenzione di rifiuti alimentari (lo sfuso infatti permette di comprare tanta merce quanto serve al consumo). Parliamo insomma di quelli trasparentissimi, con cui si comprano mele e pere e su cui si appiccica l’etichetta del prezzo, spesso ahinoi non compostabile né biodegradabile.
Ora tocca all’Italia mettersi al passo, e lo fa infine con la legge 123 del 3 agosto 2017 – governo Renzi, ministro dell’Ambiente Galletti – che creerà più di qualche polemica: uno perché si decide di mettere a pagamento praticamente tutte le buste, quelle ultraleggere, quelle leggere ma anche quelle superiori ai 200 micron, specificando che “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto”. Due perché “è guerra” anche a quelle di materiale ultraleggero, che la normativa europea invece “salvava” da qualsivoglia intervento. In Italia invece no, in nome della riduzione dell’uso della plastica si stabilisce che dovranno essere non solo biodegradabili, compostabili e a pagamento ma anche che dovranno contenere una percentuale via via sempre più alta di “materia prima rinnovabile”: era il 40 per cento fino al 1 gennaio di quest’anno, ora è il 50% e entro il 1 gennaio del 2021 dovrà arrivare al 60 per cento. Una esagerazione? Visto che le buste sono già prodotte con un materiale che deve per legge essere biodegradabile e compostabile perché farle pagare, visto che la direttiva europea non lo prevede? In realtà non è proprio così. Anzi, la normativa europea contiene in un passaggio la previsione della prossima sfida. Nel lasciare ampio margine ai Paesi sugli strumenti da adottare per ridurre l’uso delle buste in plastica, infatti, specifica che questi dovrebbero essere usati anche “in considerazione di eventuali effetti nocivi di sostituzione”. Cioè, l’Europa invita a non rischiare di ritrovarsi punto e a capo con una super produzione di buste in bioplastica e quindi considerate – come già accaduto con quelle in plastica – economiche e innocue, visto che produrre qualsiasi cosa implica comunque un consumo di risorse, una produzione di rifiuti e conseguente necessità di smaltimento e trattamento. La bioplastica, insomma, non è la panacea di tutti i mali. Per questo il vero obiettivo dovrebbe essere una riduzione del consumo usa e getta, anche attraverso il riuso.

Una storia a lieto fine, ma non troppo
Oggi in Italia le buste di plastica non sono ancora totalmente sparite ma certamente negli ultimi anni c’è stata una vera e propria rivoluzione. La grande distribuzione si è rapidamente adeguata e oggi è quasi impossibile trovare un supermercato che non distribuisca buste di plastica leggere e ultraleggere compostabili in linea con la normativa armonizzata europea. Basta guardare il sacchetto: per legge deve esserci scritto che è compostabile, riportare la normativa europea (la UNI EN 13432:2002) e dichiarare che sono utilizzabili per la raccolta dei rifiuti organici. Spesso le stesse buste sono distribuite anche da altri punti vendita, come le farmacie e alcuni negozi di abbigliamento. Ogni anno l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, deve presentare un rapporto da inviare all’Unione europea sulla situazione delle buste di plastica. In quella relativa al 2018 si dice che ormai in Italia “le buste di plastica di materiale leggero e ultraleggero sono scarsamente prodotte”. Non viene riportato il dato pro capite ma è probabile che l’Italia sia al di sotto ormai dell’utilizzo di 40 borse procapite di plastica, che era l’obiettivo da raggiungere nel 2025. Capire però se siamo in linea con la normativa europea è un altro paio di maniche, perché la produzione di buste è letteralmente esplosa: nel 2018 ne sono state prodotte quasi 85mila tonnellate con una crescita di circa 10mila tonnellate rispetto all’anno precedente. Il sorprendente dato, visto che lo scopo di tutta questa complessa vicenda era la riduzione della produzione, sarebbe da attribuire proprio alle buste compostabili e biodegradabili, che infatti crescono di quasi 20mila tonnellate. Questo dato viene messo in relazione a quello della raccolta dell’umido, che infatti sale anch’esso.
Certamente è un’ottima notizia, eppure bisogna andarci piano e considerare anche altri aspetti. L’incremento di sacchetti potrebbe non essere sostenibile anche quando sono biodegradabili e compostabili. Purtroppo non abbiamo dati per sapere quanti sacchetti monouso – per quanto compostabili – entrino nelle case degli italiani. Quanta gente arrivata alla cassa del supermercato ne prende qualcuno in più, tanto poi lo usa per la raccolta dell’umido? E quanti, invece, li utilizzano in generale per la raccolta degli scarti, per esempio di plastica o vetro – creando senza saperlo grosse difficoltà agli impianti di smaltimento che funzionano con sistemi automatizzati e quindi hanno bisogno, in estrema sintesi, di processare lo stesso materiale (plastica con plastica, vetro con vetro, carta con carta), pena un malfunzionamento della raccolta e una contaminazione della filiera?
Gli impianti italiani che trattano i rifiuti organici hanno già lanciato un grido di allarme a questo proposito: “il fatto che un materiale sia certificato come “compostabile” significa solo che esso risponde tecnicamente ai requisiti della UNI EN 13432:2002, e che tale rispondenza è stata attestata da un ente di certificazione riconosciuto. Questo però è ben diverso dal dire che lo stesso materiale possa essere, in ogni condizione e situazione, avviato a trattamento con il rifiuto organico”, scrive in un suo documento sulle bioplastiche Utilitalia, la Federazione che raccoglie le aziende che operano nei servizi pubblici di Ambiente, Acqua e Energia.
Oltretutto i dati di questi ultimi anni dimostrano che la narrativa sulla biodegradabilità porta i cittadini a compiere madornali errori. Da una parte c’è il rischio che le bioplastiche siano considerate “amiche dell’ambiente” e quindi che male c’è se butto una bottiglia di bioplastica in mare? Tanto si decompone – e non è affatto così. Dall’altra gli imballaggi “completamente compostabili” su cui alcune aziende stanno puntando sono del tutto identici alla plastica prodotta da petrolio, inducendo gli utilizzatori finali a confondere la plastica normale con la bioplastica compostabile e inquinando le raccolte differenziate. Senza contare il fatto che alcuni imballaggi biocompostabili non sempre possono venire trattati quando finiscono nella raccolta dell’umido: questo dipende dal tipo di sistema che viene utilizzato per il trattamento dell’organico sul territorio. Già si sono verificati casi in Italia in cui le aziende di smaltimento hanno chiesto ai cittadini di non utilizzare per la raccolta dell’umido le buste monouso in bioplastica perché in genere gli impianti di trattamento trasformano gli scarti di cibo in compost in un ciclo più breve di quanto impiegano i sacchi in bioplastica a decomporsi. In generale la sostituzione della bioplastica con la plastica sta comportando numerose sfide e induce molto spesso i cittadini – scarsamente informati – a fare errori quando buttano la spazzatura. Si tratta di errori molto costosi, stando a quanto dichiarato dal Consorzio Italiano Compostatori (Cic) e Corepla che, ad esempio, ha ravvisato un aumento di plastica non compostabile nella raccolta dell’organico: erano 67mila tonnellate nel 2016/2017 sono diventate 90mila nel 2019/2020. Il costo di questi “errori umani” va dai 90 ai 120 milioni di euro.
© Riproduzione riservata




